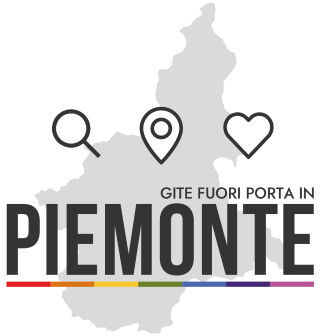La Basilica di Superga, un capolavoro di arte e storia
La Basilica di Superga è, insieme alla Mole Antonelliana, uno dei simboli della città di Torino. Uno dei capolavori settecenteschi dove l’arte, la storia e la cultura si intrecciano e creano un’atmosfera indimenticabile.
Si trova su una collina posta nella parte nord occidentale della città, a più di 600 metri d’altitudine, da cui si può godere di un panorama mozzafiato che si stende dal Monviso fino alle vallate del Canavese e alle cime del Monte Rosa. Il suo profilo è ben visibile a chilometri di distanza e da ogni parte della città, un luogo a cui tutti i torinesi sono affezionati e che amano visitare in ogni stagione dell’anno.
Basilica di Superga – **Torino **
![]() C. Ciardi (Dal Gruppo Facebook Gite fuori porta in Piemonte)
C. Ciardi (Dal Gruppo Facebook Gite fuori porta in Piemonte)
Una storia lunga e travagliata
Il nome Superga, che indica anche il colle su cui sorge la Basilica, sembra abbia lontane origini longobarde o germaniche. Alcuni sostengono che sia riconducibile ad una donna di stirpe longobarda, Saroperga, proprietaria di gran parte dei terreni collinari, altri invece lo riconducono al toponimo germanico Serrapergia, ma in entrambi i casi non esistono fonti storiche che possano confermare l’una o l’altra ipotesi.
Ciò che è storicamente provato è che il 2 settembre 1706, il Duca di Savoia Vittorio Amedeo II e il Principe di Carignano Eugenio di Savoia siano saliti sul colle di Superga, per osservare l’assedio di Torino da parte degli eserciti francesi e spagnoli, che tentavano di conquistare la città.
Il Duca di Savoia, preoccupato per le sorti di Torino, che da quattro mesi veniva duramente bombardata, entrò nella chiesetta che si trovava sul colle e, durante la funzione religiosa, si inginocchio davanti alla statua della Madonna per chiedere la grazia e pronunciare un voto solenne che consisteva, in caso di vittoria, nell’edificazione di un tempio dedicato alla Vergine. La statua si trova ancora oggi all’interno della Basilica e viene venerata nella famosa Cappella del Voto.
All’alba del 7 settembre 1706, gli eserciti si scontrarono nella zona compresa tra Lucento e Madonna di Campagna e solo nel tardo pomeriggio i piemontesi ebbero la meglio, scacciando le truppe francesi e spagnole, con ingenti perdite sul campo di battaglia su entrambi i fronti. Alla vittoria, del tutto inaspettata, seguì un periodo di grande euforia e festeggiamenti. Il Duca di Savoia, ancor prima che finisse la Guerra di Successione Spagnola, venne incoronato Re di Sicilia e, come giurato, nel 1711 affidò il progetto della Basilica all’architetto messinese Filippo Juvarra, uno dei principali esponenti del barocco piemontese.
Torino era una città distrutta e provata dai lunghi anni di guerra e soprattutto in forti difficoltà economiche, per cui il progetto della Basilica, nonostante fosse stato più volte sollecitato, fu rimandato di qualche anno.
Gli effettivi lavori di costruzione iniziarono nel 1717 e durarono circa quattordici anni, tra molte difficoltà legate alle strade d’accesso al colle, particolarmente impervie, scomode e sassose, tanto che tutti i materiali vennero trasportati fino alla sommità a dorso d’asino, perché nessun altro mezzo di trasporto risultava adatto.
Nel 1714, Filippo Juvarra, nominato da Vittorio Amedeo II, architetto della “Real Casa”, si era trasferito a Torino dalla Sicilia e aveva iniziato a lavorare su diversi progetti per i Savoia e altri regnanti in Italia ed Europa, tra cui la Reggia di Venaria, la Palazzina di Stupinigi, Palazzo Madama e molti altri edifici.
Una delle prime difficoltà che Juvarra dovette affrontare, oltre alle strade di accesso difficilmente percorribili, fu la conformazione naturale del colle, che non permetteva la realizzazione del progetto. Si decise quindi di abbassare la cima del colle di ben quaranta metri e abbattere l’antica chiesa in cui il Duca di Savoia aveva pronunciato il suo voto solenne.
Nel 1716 , un centinaio di operai iniziarono i lavori di scavo, che si conclusero dopo circa un anno, utilizzando solo pale, picconi e carriole. Come da indicazioni dello stesso Juvarra, tutto il materiale che venne scavato, venne depositato ai piedi della collina per essere riutilizzato durante la costruzione della Basilica, e questa zona venne denominata “Sassi”, così come viene tuttora chiamata dai torinesi.
Una volta terminato lo scavo, nel 1717, venne posata la prima pietra e cominciarono i lavori di edificazione, utilizzando esclusivamente materiali provenienti dalle cave piemontesi di Frabosa, Gassino, Foresto, Rossasco e Busca-Dronero. La cava di Frabosa, per i mezzi di trasporto di allora, si trovava molto lontano da Torino, per cui i materiali venivano prima trasportati fino a Chieri, dove erano lavorati sul posto, per essere trasferiti in un secondo momento a Superga.
La strada per arrivare in cima al colle seguiva un lungo percorso, spesso interrotto da frane o reso impraticabile dalle piogge, e questo faceva lievitare notevolmente i costi per la Real Casa, ma soprattutto rendeva il lavoro degli operai estremamente faticoso e difficile.
Finalmente, verso la fine del 1730 i lavori di costruzione erano quasi conclusi, compresi i caseggiati che avrebbero accolto i convittori, parte della residenza in cui avrebbero potuto alloggiare i Reali, e la cripta dove sarebbero state tumulate le loro spoglie.
Nel frattempo Vittorio Amedeo II aveva abdicato a favore del figlio Carlo Emanuele III, il quale nel 1731 nominò dodici convittori e fissò la data d’inaugurazione della Basilica. La sera del 31 ottobre 1731 la chiesa venne benedetta dall’elemosiniere del Re e il giorno seguente l’edificio venne aperto al pubblico.
Il costo complessivo di quest’opera è tuttora difficile da calcolare, perché nei registri vennero comprese anche altre spese relative ad altri edifici in costruzione nello stesso periodo, ma da una stima approssimativa si dovrebbe aggirare intorno a due milioni di antiche lire piemontesi.
Nel 1799, in seguito alle rivolte dei giacobini e all’instaurazione della Repubblica, si pensò di trasformare la Basilica in un Tempio della Riconoscenza, traslando le salme dei Savoia per far posto ai caduti piemontesi. Venne anche proposto di abbattere la chiesa, ma grazie all’opposizione dei rivoluzionari piemontesi, il progetto di demolizione non venne portato a compimento.
Fino al 1855, la gestione della Basilica venne affidata alla “Reale Congregazione della Madonna di Superga”, istituita un anno prima dell’inaugurazione, che successivamente divenne Accademia Ecclesiastica di Superga, un importante centro di studi teologici e canonici.
La Basilica di Superga entrò a far parte del patrimonio dei torinesi e di tutti i piemontesi, e nel 1884 venne finalmente aperta la funicolare che ancora oggi collega il quartiere Sassi con il piazzale antistante la chiesa, superando così le difficoltà di accesso a tutti i cittadini. La linea, lunga più di 3 chilometri, è stata trasformata in tranvia a cremagliera nel 1934 e ancora oggi utilizza il materiale rotabile originale e i vagoni della prima funicolare del 1884.
Superga è anche legata ad uno degli eventi più tragici che hanno colpito la sensibilità dei torinesi e di tutti gli amanti dello sport: il 4 maggio 1949 l’intera squadra del Grande Torino, una delle società più importanti e vincenti di tutta la storia del calcio italiano, morì schiantandosi sul retro della Basilica. L’aereo proveniva da Lisbona, dove la squadra aveva disputato una partita amichevole con il Benfica, e alle 17:03 andò a sbattere contro il muraglione del terrapieno posteriore della Basilica, causando la morte di tutti i giocatori, i dirigenti, gli accompagnatori, l’equipaggio e di tre giornalisti sportivi.
L’impatto emotivo di questa tragedia fu enorme e quasi un milione di persone parteciparono ai funerali a Torino. Il tragico evento è da allora ricordato con una lapide posta nel punto esatto dove avvenne lo schianto e, durante tutto l’anno, è meta di pellegrinaggi da parte di sportivi e appassionati di calcio. Inoltre, ogni anno, il 4 maggio, viene celebrata una messa solenne in ricordo delle 31 vittime.
Nel 2021, per un mancato accordo tra lo Stato Italiano e l’ordine religioso dei Servi di Maria, che da più di cinquant’anni gestiva il patrimonio di Superga, sembrava che l’intero complesso dovesse essere chiuso al pubblico. Un gravissimo danno per tutta la città e i cittadini torinesi. Fortunatamente, grazie all’intervento dell’Arcivescovo Cesare Nosiglia, la gestione è stata affidata al SERMIG, il Servizio Missionario Giovani fondato da Ernesto Olivero nel 1964, e per il momento la chiusura è stata scongiurata, permettendo a tutti, cittadini e turisti, di continuare ad ammirare il panorama e le bellezze di questo monumento storico e artistico.
Oggi. Siamo andati ad Alpe Mera posto bellissimo e stupendo per i bambini ![]()
![]()
![]()
![]() L. Eccona (Dal Gruppo Facebook Gite fuori porta in Piemonte)
L. Eccona (Dal Gruppo Facebook Gite fuori porta in Piemonte)
Cosa vedere a Superga
La Basilica
Chi sale a Superga, lo fa principalmente per visitare la Basilica, un edificio dalle dimensioni imponenti, visibile anche da grandi distanze e da tutta la città di Torino. Complessivamente, la chiesa è lunga 51 metri e la cupola arriva alla notevole altezza di 75 metri, a cui vanno aggiunti i 672 metri di altitudine del colle.
Il panorama è assolutamente mozzafiato sia sull’intera città di Torino, sia sulla catena delle Alpi che circondano la pianura. Uno spettacolo da non perdere per chiunque visiti Torino!
L’architettura della Basilica è scenograficamente studiata per esaltare il potere della casata sabauda, con le otto colonne che arricchiscono il pronao, i due campanili simmetrici, e la cupola, un vero capolavoro con le sue due calotte, una esterna e una interna, fra cui si frappone un’ampia intercapedine.
L’interno della Basilica è impreziosito da sei cappelle, cinque maestosi altari, fra cui l’Altare Maggiore, e statue e decorazioni in bianco marmo di Carrara.
Di particolare interesse storico e artistico è la Cappella del Voto, dove viene tuttora conservata la secentesca statua lignea della Madonna delle Grazie, davanti a cui si inginocchio il Duca Vittorio Amedeo II per pronunciare il suo voto e propiziare la vittoria dell’esercito piemontese.
La splendida Superga !!!!! ( To )
![]() S. Rocca (Dal Gruppo Facebook Gite fuori porta in Piemonte)
S. Rocca (Dal Gruppo Facebook Gite fuori porta in Piemonte)
Il Chiostro e La Sala dei Papi
Il Chiostro venne progettato da Filippo Juvarra ed è costituito da un doppio ordine di archi, che circondano un giardino all’italiana, con un labirinto di siepi di bosso. Al centro del giardino si trova il pozzo, sormontato da un tettuccio, che ricorda una pagoda cinese.
Dal Chiostro si può accedere alla Sala dei Papi, originariamente utilizzata come refettorio estivo dai convittori e trasformata in pinacoteca nel 1876.
I 265 dipinti raffiguranti i Papi sono disposti a mosaico, in modo simile alla collezione presente nella Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma, e sulla parete principale si può ammirare il ritratto di Papa Francesco.
Dalla Sala dei Papi, tramite una scalinata, si può accedere alla Cripta dove sono conservate le Tombe Reali. Alla fine dello scalone, si viene accolti dalla statua in marmo di Carrara dell’Arcangelo Michele, ritratto nell’atto di sconfiggere il demonio e, percorrendo un breve corridoio, si accede alla Cripta.
Basilica di Superga – Torino
![]() Antonio’s Photos (Dal Gruppo Facebook Gite fuori porta in Piemonte)
Antonio’s Photos (Dal Gruppo Facebook Gite fuori porta in Piemonte)
Le Tombe Reali
La Cripta, dove sono conservate le Tombe Reali, venne realizzata su richiesta del Re Vittorio Amedeo III, il quale volle realizzare il sogno del nonno, Vittorio Amedeo II, il quale desiderava un mausoleo dove potessero riposare i defunti della Famiglia Reale.
Il progetto venne affidato all’architetto Francesco Martinez, nipote di Filippo Juvarra, il quale lo concretizzò tra il 1774 e il 1778.
La struttura della Cripta è a croce latina e, al centro, ospita il Sarcofago del Re in onice di Busca e marmo bianco, dove sono conservate le spoglie di Carlo Alberto, ultimo Re di Sardegna, famoso per aver concesso lo “Statuto Albertino” e aver trasformato il Regno di Sardegna in una Monarchia Costituzionale. Sulle due ali laterali si possono invece ammirare la Sala degli Infanti e la Sala delle Regine.
La Sala degli Infanti era destinata a ospitare le salme dei principi sabaudi morti in tenera età e attualmente conserva i resti di 14 bambini e 9 adulti, tra cui la principessa Maria Clotilde di Savoia, la “Santa di Moncalieri”, moglie di Gerolamo Bonaparte, il cui corpo è sepolto accanto a lei.
La Sala delle Regine accoglie invece le salme delle Regine sabaude. Di particolare pregio è il monumento funebre di Maria Teresa di Toscana – Asburgo, moglie di Carlo Alberto, realizzato da Sante Varni e raffigurante la Carità.
Non lontano si trova il monumento funebre della Regina Maria Adelaide d’Asburgo, prima moglie di Re Vittorio Emanuele II, la quale morì a soli 33 anni di tifo e indebolita dalle numerose gravidanze.
Infine, è da notare il monumento funebre di Maria Vittoria dal Pozzo, moglie del Primo Duca d’Aosta, Amedeo Ferdinando, Sovrano di Spagna, la quale si dedicò ad opere filantropiche, rivolte soprattutto a sostenere le lavandaie. Alla sua morte, per riconoscenza, le donne inviarono corone di fiori di seta realizzate artigianalmente, ancora oggi conservate nella teca posta accanto al monumento.
L’Appartamento Reale
L’Appartamento Reale, al momento chiuso a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, faceva parte del progetto originario del complesso juvarriano e prevedeva un edificio a tre piani da realizzare accanto al convento preesistente.
Vittorio Amedeo II desiderava un luogo in cui ritirarsi negli ultimi anni di vita e commissionò la realizzazione di una residenza reale a Filippo Juvarra, che però non riuscì a concludere l’opera e la costruzione rimase incompiuta.
Non potendo usufruire di una residenza, alcune stanze del primo piano del Convento vennero destinate ai componenti della Famiglia Reale durante le loro brevi visite a Superga, così come il Salone del Re, al piano inferiore destinato alle cerimonie.
L’Appartamento Reale è costituito da 5 ambienti: Anticamera, Prima Sala di Ricevimento, Gabinetto da Toeletta, Sala Verde e Sala Rosa. Il percorso di visita inizia dall’Anticamera, dove si può ammirare una splendida scultura di Benedetto Cacciatori, raffigurante un bambino in una cesta. Quest’opera potrebbe avere una doppia interpretazione, da una parte potrebbe essere propiziatoria per una nuova nascita e dall’altra essere utilizzata come monumento funebre. Dall’Anticamera si accede alla Sala di Ricevimento, dove troneggia il busto del Re Carlo Alberto, attorniato dai ritratti dei Prefetti della Basilica di Superga.
Proseguendo il percorso, si arriva nella Sala Verde, dove si può ammirare un originale tavolo gueridon tardo ottocentesco, decorato nella parte centrale da un motivo a scacchiera.
In questa sala sono importanti i cinque quadri commissionati da Carlo Alberto, facenti parte della serie dei dipinti destinati ad arredare la Sala del Caffè di Palazzo Reale.
Procedendo con l’itinerario, si entra nella Sala Rosa, alle cui pareti si può osservare un dipinto della Madonna con Bambino di manifattura spagnola, arricchito da una cornice dorata a motivi floreali.
Infine, la visita si conclude nella Sala da Pranzo Reale, o Salone del Re, arredata con mobili d’epoca e ornata da 4 quadri che coprono l’intera parete e rappresentano i sovrani Vittorio Amedeo II, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II e Umberto I, particolarmente significativi per la storia della Basilica di Superga.
Nel Settecento, durante il governo francese e l’occupazione napoleonica, gli arredi dell’appartamento vennero razziati, ma nel 1814, con il ritorno al potere dei Savoia, l’Appartamento Reale venne riallestito.
Purtroppo, agli inizi del Novecento, l’Appartamento venne utilizzato come Caserma dei Carabinieri e, durante la Seconda Guerra Mondiale, divenne rifugio per gli sfollati, con la conseguente dispersione di gran parte degli arredi rimasti.
Attualmente, l’Appartamento è stato riprodotto fedelmente al piano terra dell’edificio, utilizzando alcuni degli arredi superstiti e alcuni mobili d’epoca provenienti da Palazzo Reale.
Salita alla Cupola
Dall’interno della Basilica è possibile accedere alla Cupola, attraverso una scala a chiocciola formata da 131 gradini, che permettono di raggiungere la balconata esterna della cupola, da cui affacciarsi per ammirare il meraviglioso panorama su Torino e le montagne circostanti, tra cui il Monviso, il Gruppo dell’Orsiera, il Rocciamelone, il Gran paradiso, il Gruppo degli Apostoli, la Torre di Lavina, e la Punta Doufour del Monte Rosa.
M. Rusu (Dal Gruppo Facebook Gite fuori porta in Piemonte)
Tariffe e Orari
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI OBBLIGO DI INGRESSO CON MASCHERINA.
Il sito non è accessibile alle persone con disabilità fisica e in carrozzina, e non è consentito l’ingresso agli animali, perché si tratta di un luogo di culto.
Si può visitare gratuitamente la Basilica tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Ogni domenica viene celebrata la Santa Messa alle ore 11.30.
Tombe Reali e Appartamento Reale
Prezzi:
Biglietto intero: € 5,00 Tombe Reali o Appartamento Reale
Biglietto ridotto: € 4,00 acquistando un biglietto per l’ingresso alle Tombe Reali o Appartamento Reale si ha diritto alla riduzione sul secondo spazio museale.
Sono previste riduzioni per GRUPPI DI MINIMO 20 PERSONE, Soci TCI, ACI, FAI, ARCI, Forze dell’Ordine, Dipendenti Ministero Beni Culturali, Studenti, Scolaresche, Giornalisti, Insegnanti, Over 65, soci CTS e studenti ISIC CARD, Cral Convenzionati e possessori di CartaOro di CronacaQui.
Biglietto gratuito: Abbonamento Musei, To+Piemonte Card, Royal Card, Guide Turistiche, Portatori di Handicap, Accompagnatori di un gruppo minimo 20 persone e bambini sotto i 12 anni.
Orari:
Tombe Sabaude:
Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica e Lunedì:
ore 10.30-13.30 (ultimo ingresso ore 13.00) – 14.30-18.00 (ultimo ingresso ore 17.30)
Appartamento Reale:
CHIUSO
Gli ingressi sono contingentati e accompagnati.
Salita alla Cupola Juvarriana
Prezzi:
Biglietto intero: € 3,00
Biglietto ridotto: € 2,00
Sono previste riduzioni per GRUPPI DI MINIMO 20 PERSONE, Soci TCI, ACI, FAI, ARCI, Forze dell’Ordine, Dipendenti Ministero Beni Culturali, Studenti, Scolaresche, Giornalisti, Insegnanti, Over 65, soci CTS e studenti ISIC CARD.
Biglietto gratuito: Abbonamento Musei, To+Piemonte Card, Royal Card, Guide Turistiche, Portatori di Handicap, Accompagnatori di un gruppo (minimo 20 persone) e bambini sotto i 12 anni.
Orari:
Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica e Lunedì:
ore 10.30-13.30 (ultima salita ore 13.00) – 14.30-18.00 (ultima salita ore 17.30).
Le salite sono contingentate e assistite.
Per motivi di sicurezza, in caso di maltempo non si effettua la Salita alla Cupola.
Per informazioni relative alle visite alle Tombe Reali, all’Appartamento Reale e per la Salita alla Cupola Juvarriana, telefonare al numero 011/8997456 oppure inviare una mail a prenotazioni@basilicadisuperga.com.